Metodo o intuizione?
Un falso dilemma che attraversa la nostra società. Ricordando le splendide parole di Hermann Hesse.
Nella nostra vita quotidiana spesso adottiamo in modo manicheo e superficiale uno di questi due estremi:
Seguiamo in modo asettico e burocratico metodi e procedure che definiscono i passi secondo i quali arrivare ad affrontare un problema o a prendere una decisione.
Ci fidiamo del nostro istinto, alimentato e sostenuto dal nostro vissuto. Spesso ciò si traduce nell’utilizzare singoli casi, singole esperienze per derivare osservazioni e indicazioni di carattere generale.
È l’antica contrapposizione tra metodo e intuizione che da sempre attraversa la nostra società, sia che si considerino le nostre vicende personali che quelle professionali o istituzionali.
Nella vita professionale ci sono i rigorosi (spesso noi accademici, ahimé) che sono innamorati della propria costruzione intellettuale e non sanno rivederla, criticarla e declinarla alla luce delle esperienze concrete che si trovano a vivere e gestire.
All’opposto (pensate alle dinamiche presenti sui social), siamo testimoni dello svilimento dell’approfondimento tecnico/metodologico, a generalizzazioni che partendo da singoli casi traggono lezioni di carattere più ampio, fino alla diffusione di presunte “verità” che si basano sul pernicioso refrain “me lo ha detto tizio” (spesso il famigerato “cugino”).
Non basta aver definito metodi rigorosi e sistematici per affrontare i problemi quotidiani. Qualunque metodo deve misurarsi con la concretezza delle esperienze, ed evolvere e mutare in funzione dei risultati empirici che si osservano e raccolgono.
Al tempo stesso, poggiarsi solo su casistiche estemporanee – episodiche e non sistemiche – è superficiale e pericoloso perché ignora la conoscenza accumulata nelle teorie e nei metodi sviluppati nel corso del tempo. Così come contare solo sul proprio istinto è sciocco e autolesionista, spesso irresponsabile.
Quel che serve, come in tanti altri contesti, è attivare un ciclo continuo e virtuoso che promuova e sostenga l’interazione critica tra metodo e intuizione, tra teoria ed esperienza empirica, tra generalità e specificità.
In altre parole, serve essere persone che coniugano una solida formazione metodologica e professionale con una grande maturità e capacità di osservazione ed ascolto.
Riflettendo su queste considerazioni mi sono tornati alla mente i principi Yin e Yang della cultura orientale e uno dei libri più suggestivi di Hermann Hesse, Narciso e Boccadoro. Così GenAI descrive i due protagonisti del romanzo:
Narciso (lo spirito): simbolizza l’ideale ascetico, la fede, la riflessione teoretica e la ricerca di una verità universale. Spesso rappresenta la tensione tra regola e intuizione, tra metodo e apertura all’esperienza.
Boccadoro (la natura): rappresenta l’istinto creativo, l’immediatezza dell’esperienza, l’eros e la sensibilità artistica. Continua a mettere in discussione la fissità di un metodo strettamente razionale, chiedendo spazio all’imprevisto e al vissuto.
Nella mia vita ho avuto la fortuna e l’opportunità di alternare esperienze che hanno di volta in volta sottolineato l’uno o l’altro dei principi. E ho capito che entrambi sono importanti, che nessuno dei due può vivere pienamente in assenza dell’altro.
Per questo non c’è niente di più bello ed utile che ricordare in chiusura un illuminante passaggio di questo immortale romanzo:
Narciso: «Parlo sul serio. Avvicinarci non è il nostro compito, come non lo fanno il sole e la luna, o il mare e la terra. Noi due, mio caro amico, siamo il sole e la luna, siamo il mare e la terra. Il nostro obiettivo non è fonderci l’uno nell’altro ma riconoscerci a vicenda, e imparare a vedere e onorare nell’altro ciò che siamo: un opposto e un completamento».




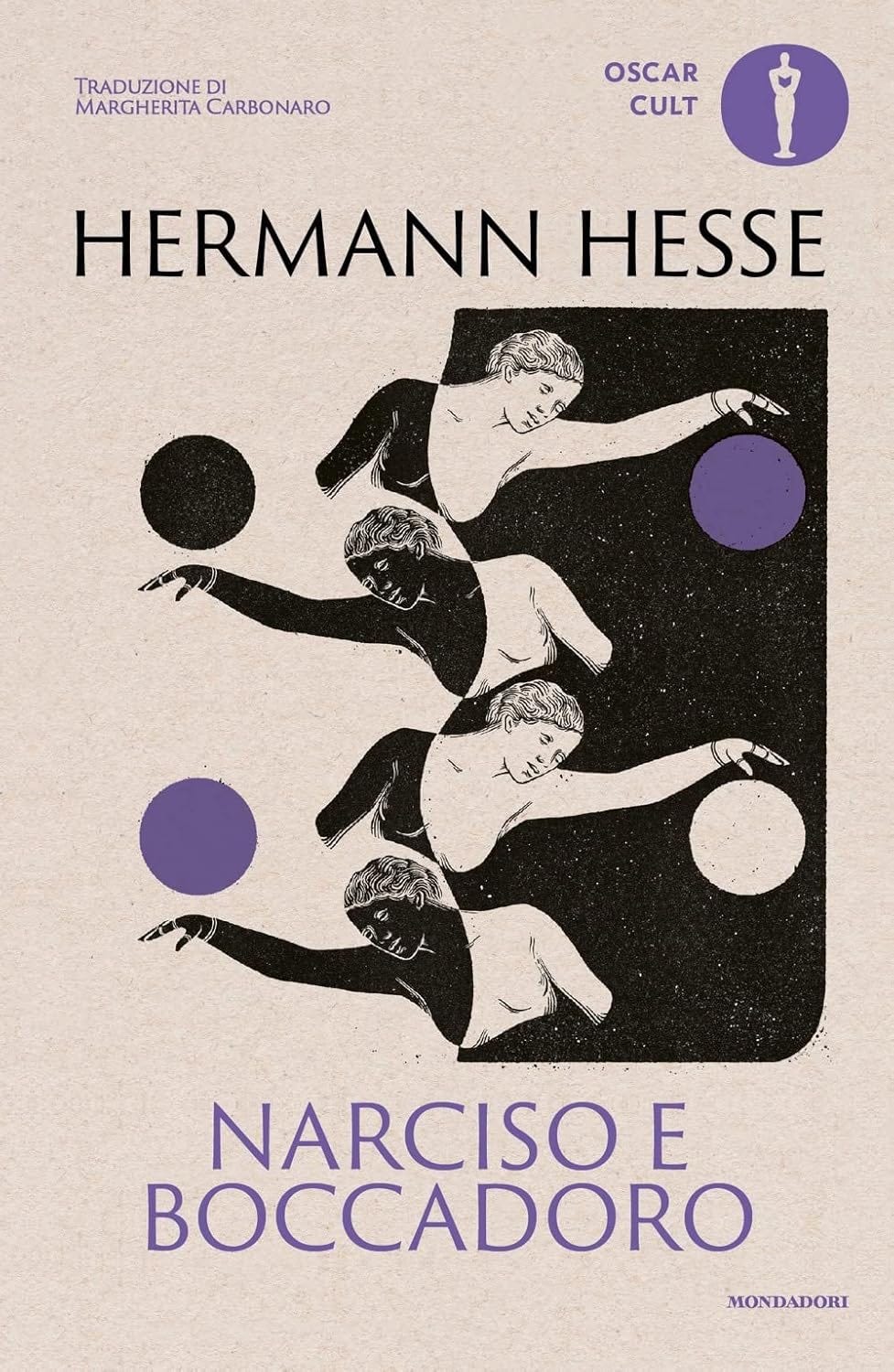
Spesso siamo stati portati a credere che l’equilibrio sia dato da una fusione degli elementi della dicotomia. Invece, quando per natura non è possibile trovare una sintesi di questo tipo, la strada più efficace è quella di avere una integrazione “compromesso”. Come un coro a due voci, o un piano ed un violino: due voci ben distinte, due strumenti ben distinti, riconoscibili, diversi. Si alternano, possono suonare o cantare insieme. Producono una armonia speciale anche grazie alla dissonanze. L’arte ce lo mostra spesso in tutti i modi, ma per le nostre menti la sintesi è più accettabile, per tanti motivi. Purtroppo la sintesi è annichilimento, mentre
l’integrazione è diversità e ricchezza, ed è una strada che richiede una mentalità aperta e duplice, in grado di convivere con un problema irrisolto: quello del dualismo. E trarne qualcosa di utile.
Dici bene caro Alfonso, il punto difficile è proprio l'ultimo: riconoscere nell'altro, che ha idee, posizioni e opinioni diverse, come l'opportunità di imparare qualcosa e di ottenere risultati che nessuno aveva in tasca singolarmente. Di fatto, invece che considerarlo complementare, lo sforzo più comune è quello di vederlo nemico o peggio di delegittimarlo. Allo stesso tempo credo che occorra anche essere attenti nel distinguere "gli altri" in buona fede - nella mia esperienza la maggioranza - da chi effettivamente ti attacca usando le idee come un pretesto. Fortunatamente sono pochi.